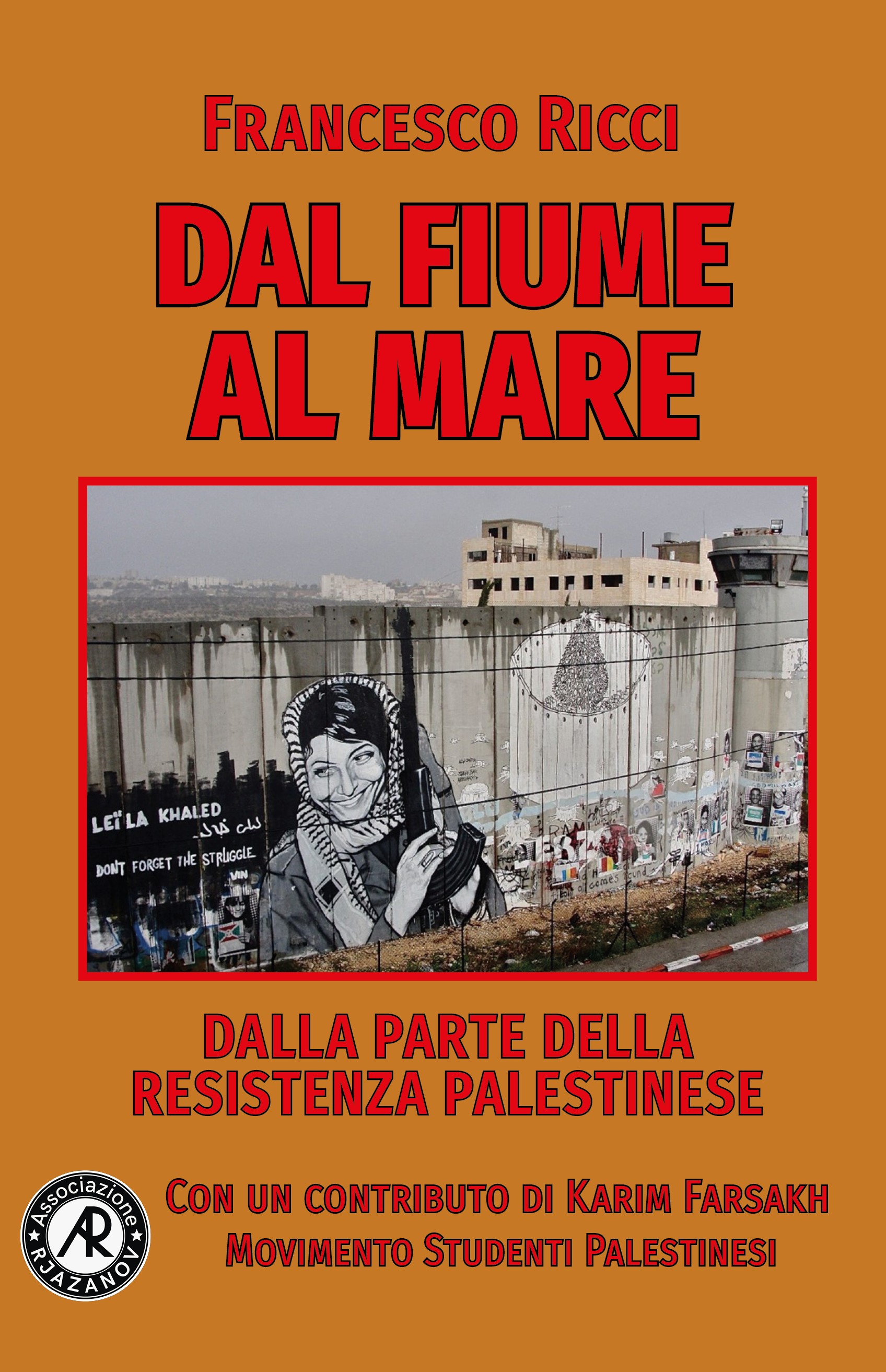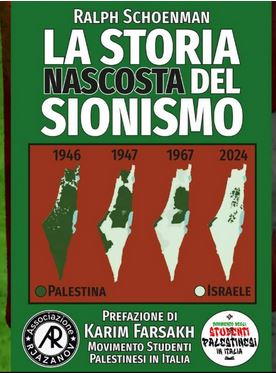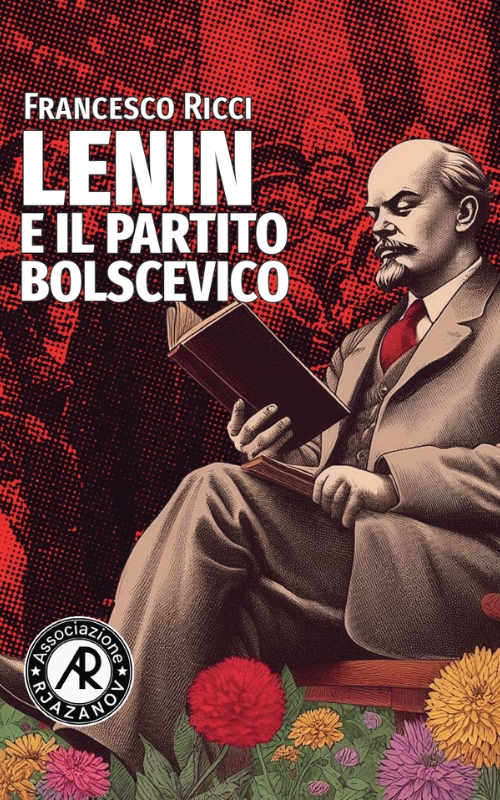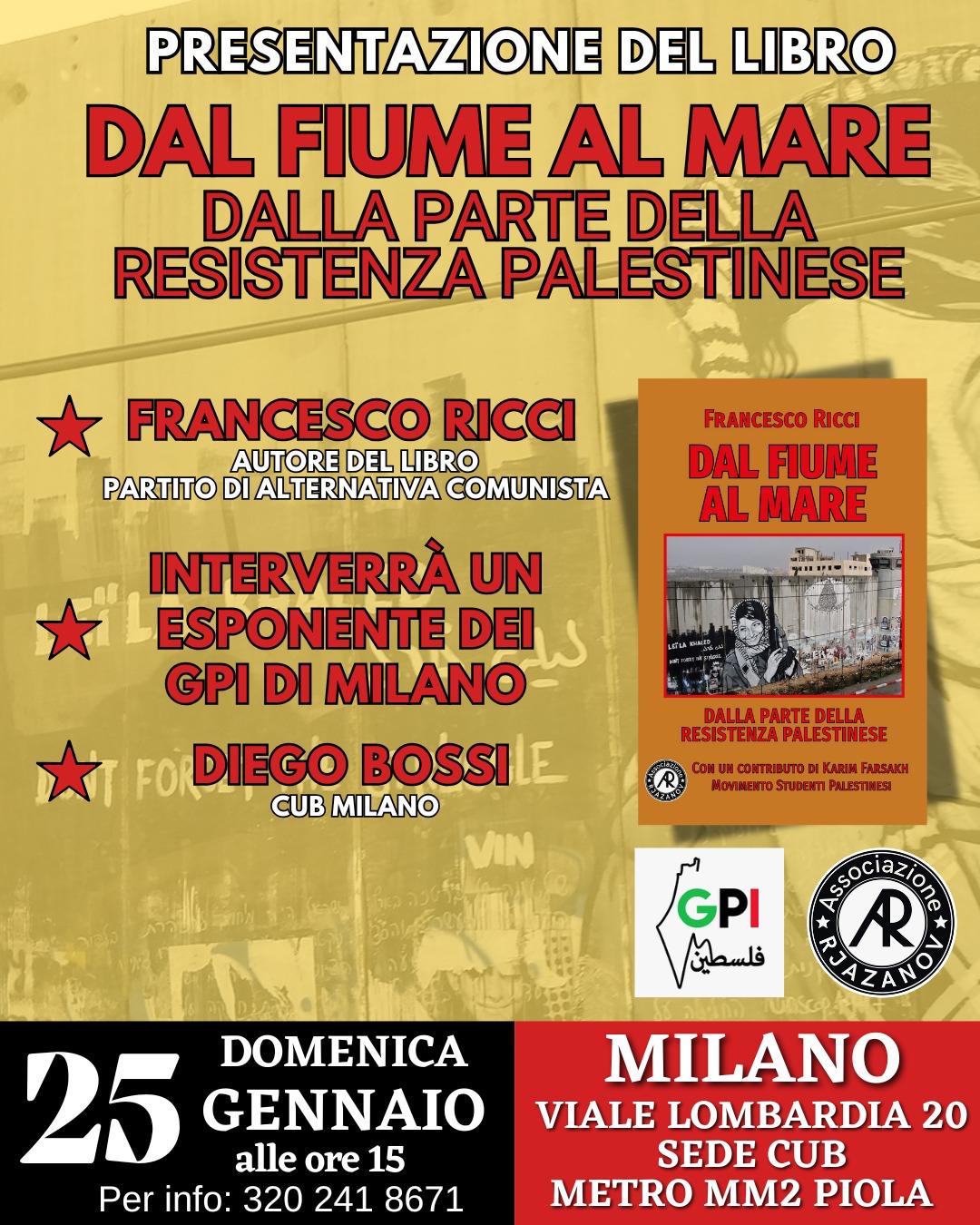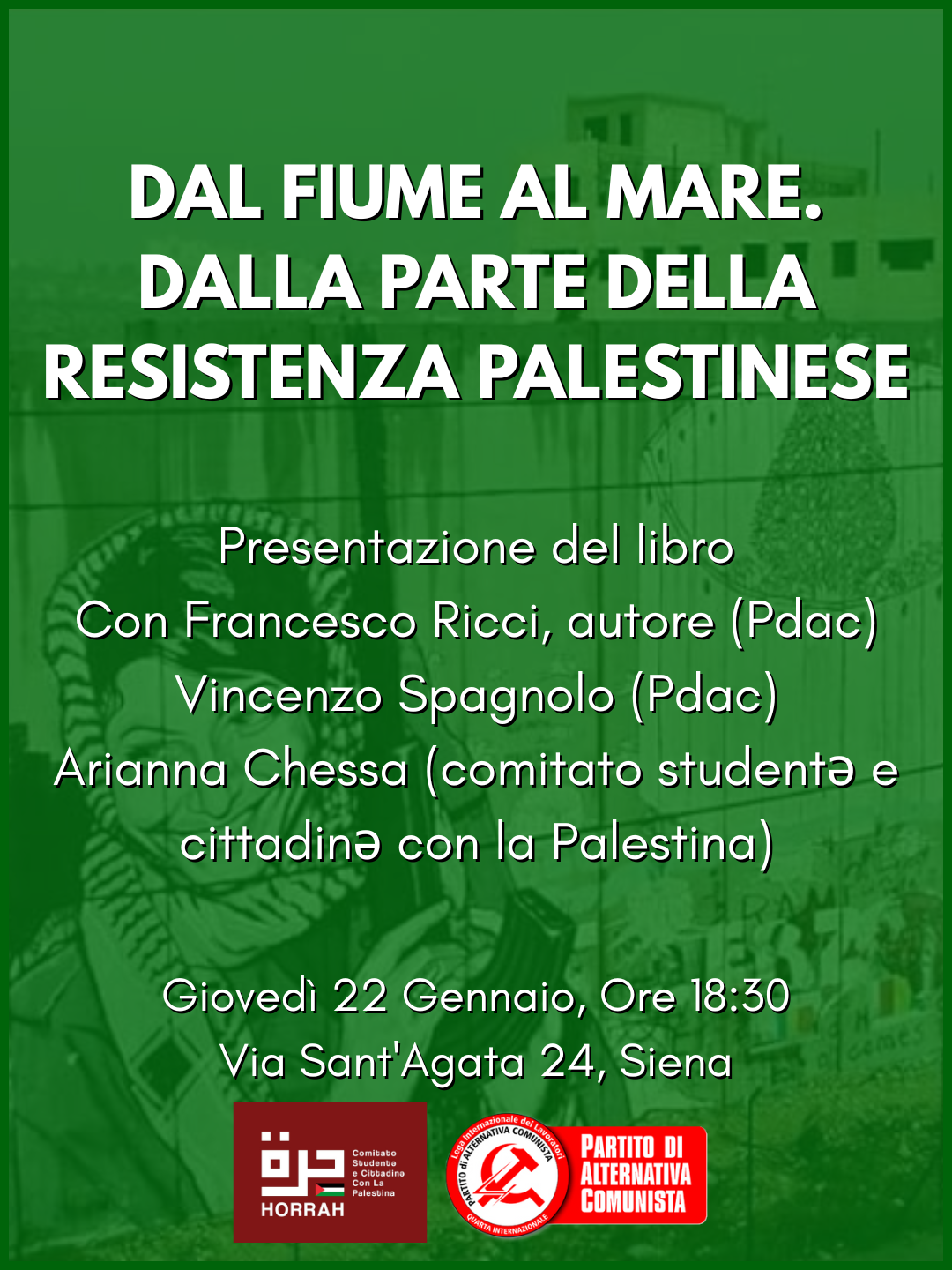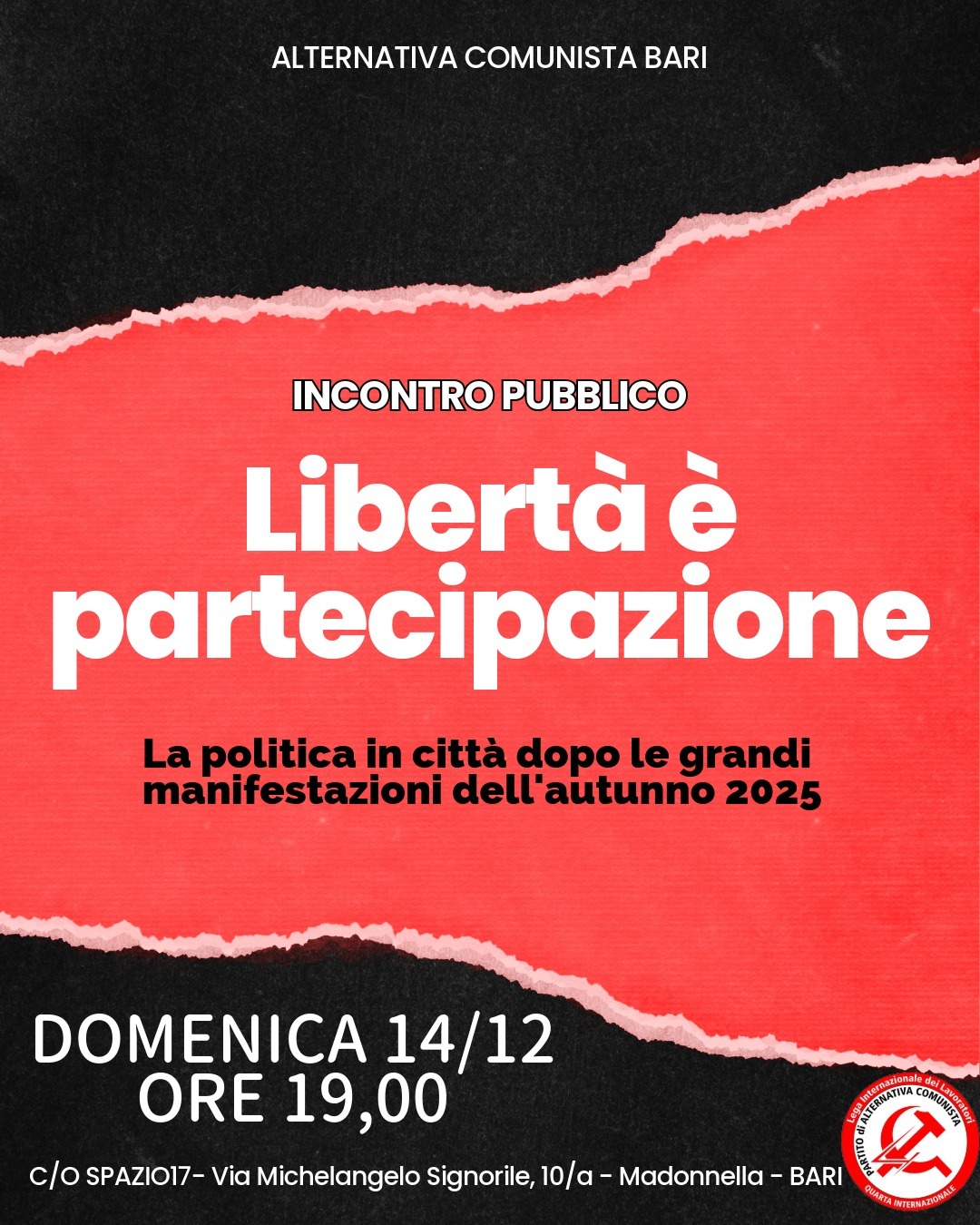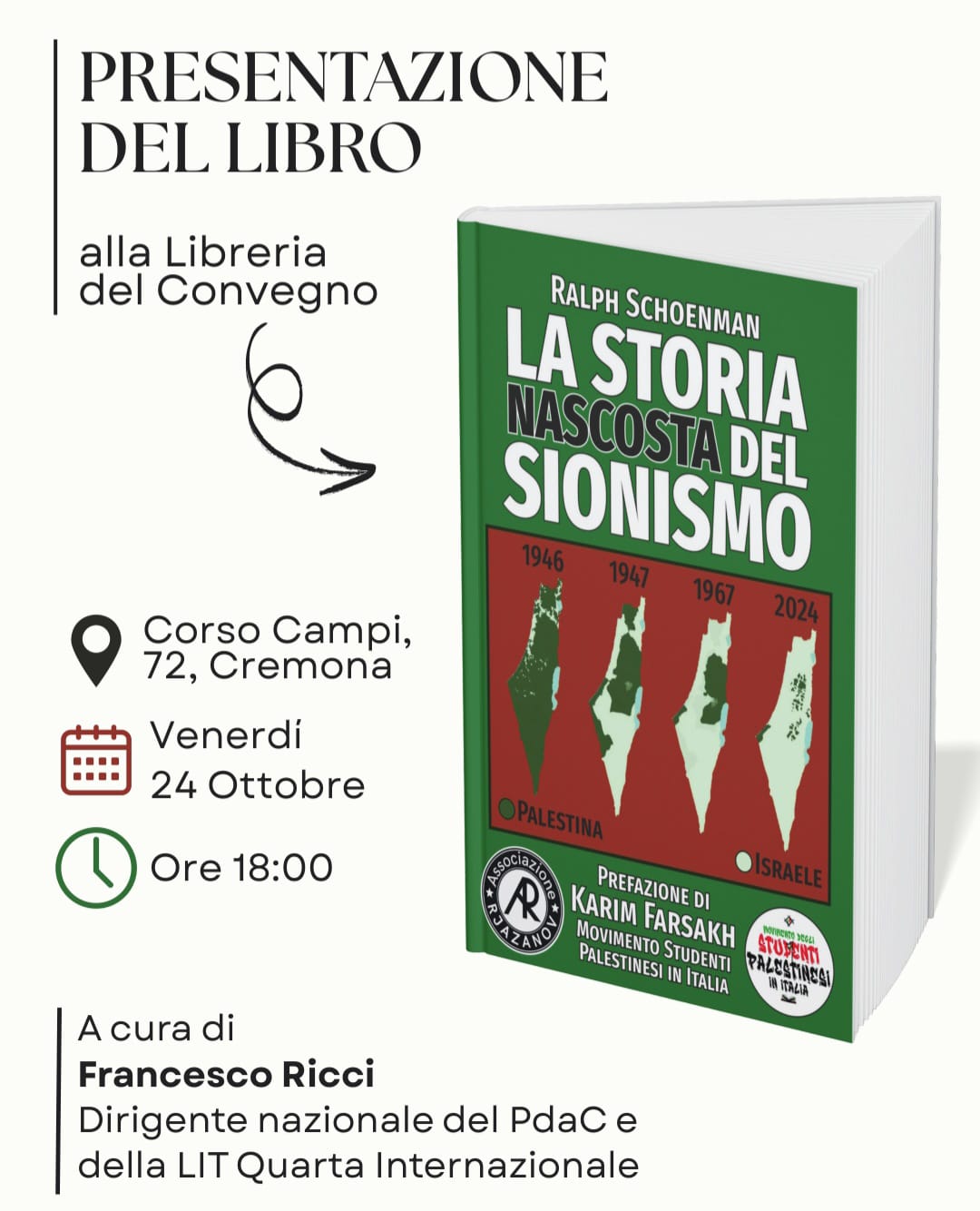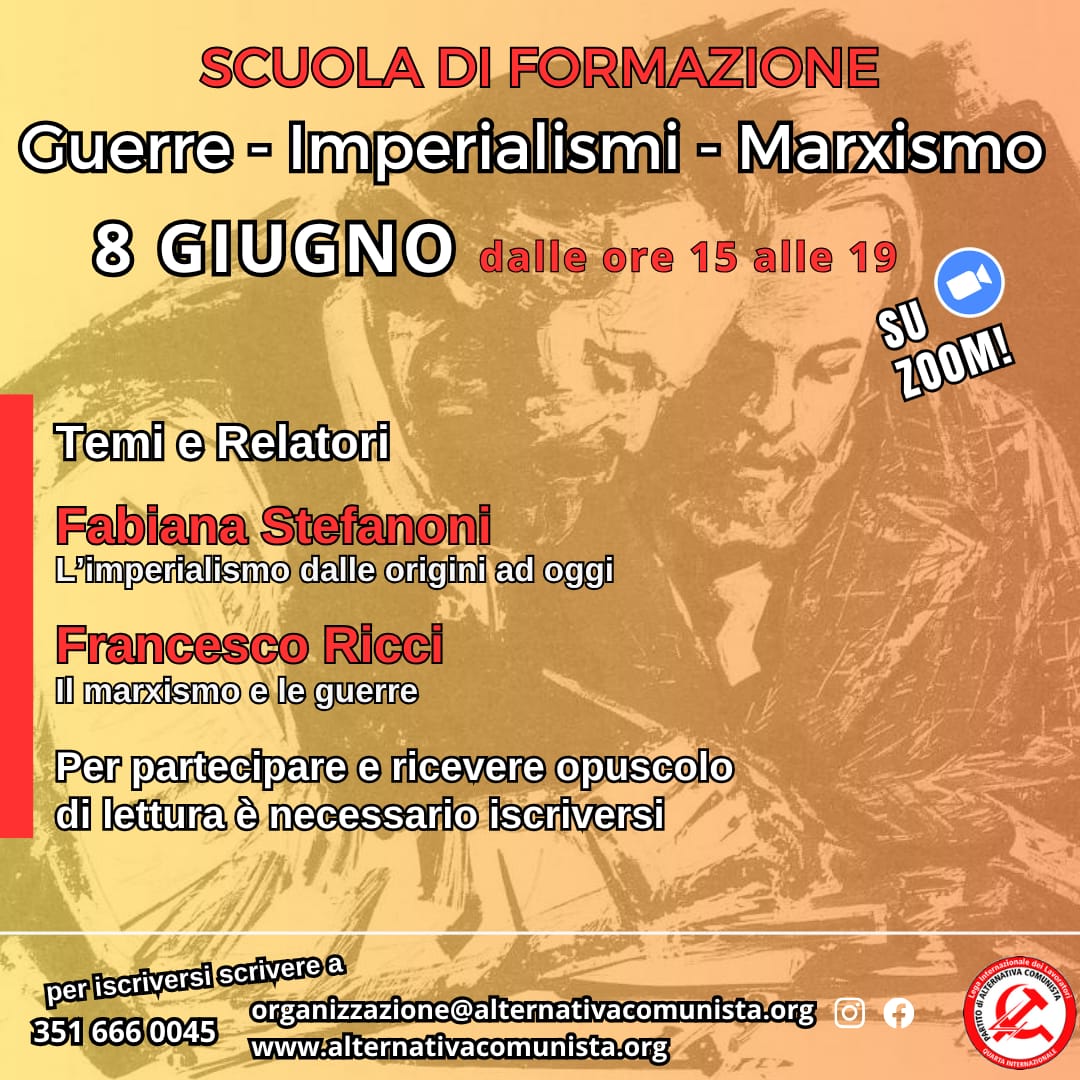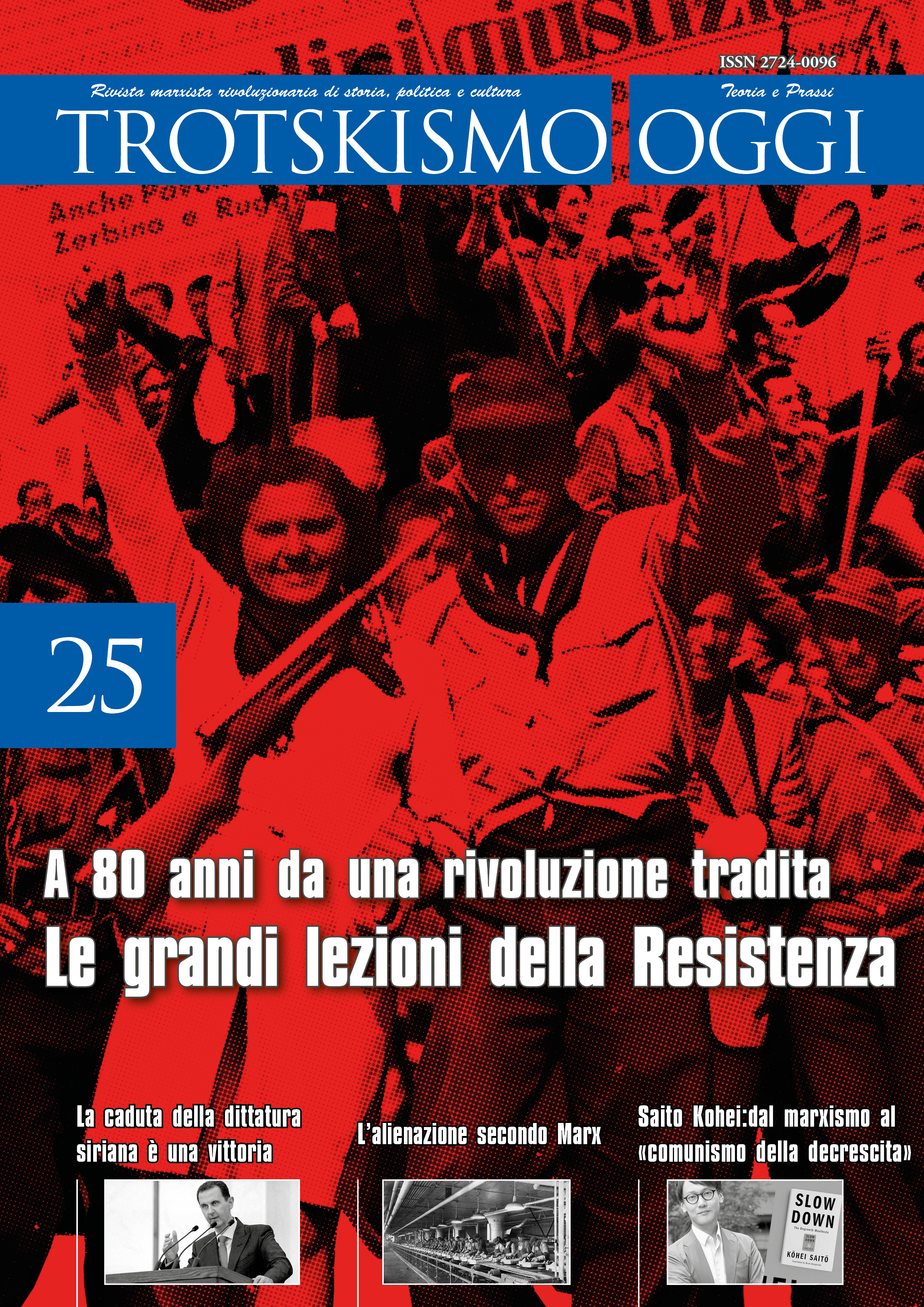La restaurazione del capitalismo negli ex Stati operai
Prefazione all’edizione russa de “Il Verdetto della Storia”
di Martín Hernández
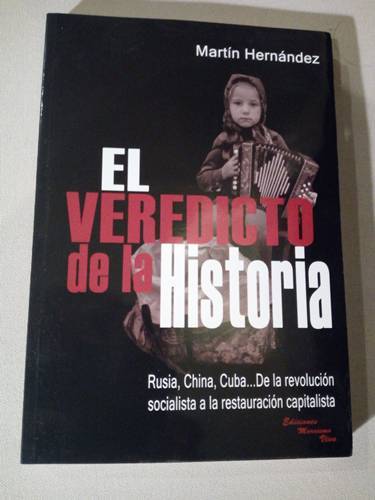
Questa nuova edizione, ora in russo, de Il Verdetto della Storia, si aggiunge a quelle già realizzate in
portoghese nel 2008; in castigliano nel 2009, e a quella che uscirà
prossimamente in inglese.
Le varie edizioni di questo libro dimostrano che esso ha
risvegliano un certo interesse tra coloro che cercano di capire quello che è
accaduto negli Stati dove, in passato, si espropriò la borghesia. In
particolare nella ex Urss e nel resto dell’Est europeo, così come in Cina e a
Cuba.
Il Verdetto contiene
vari lavori elaborati tra il 1994 e 2001. Pertanto, già sono passati più di 20
anni dalle prime elaborazioni che ho realizzato, congiuntamente a un gran
numero di compagni e amici, su un tema tanto polemico e appassionante:
rivoluzione e restaurazione negli ex Stati operai.
In questi due decenni sono stati molti i cambiamenti avvenuti in
questi Stati, tali che avrebbero potuto indurmi a realizzare un'attualizzazione
di questo libro e non semplicemente una riedizione. Tuttavia ho optato per
quest’ultima alternativa, considerando che le osservazioni e le conclusioni
raggiunte quasi vent’anni fa, nell’essenziale, si sono dimostrate corrette; ma
ciò non significa che, obiettivamente, le stesse non richiedano varie
chiarificazioni, attualizzazioni e persino correzioni.
Quando questi testi sono stati scritti, negli anni ‘90, c'era un
grande dibattito tra gli intellettuali e tra le organizzazioni di sinistra sul
significato dei processi dell’Est. Questo dibattito si protrae fino ad oggi, e
non ci sarebbe da meravigliarsi se, data l'importanza del tema, si continuerà a
sviluppare ancora per alcuni decenni.
Senza dubbio in quegli anni il dibattito assumeva forme differenti
da quelle attuali. Si discuteva, principalmente, se negli Stati operai fosse
stato restaurato o meno il capitalismo, ed era a partire da qui che si traevano
una serie di conclusioni, sempre molto polemiche.
Le nostre elaborazioni si scontrarono con l'ampia maggioranza di
quelle esistenti, perché già a partire dal ‘94 (certamente già con un certo
ritardo) cominciammo a segnalare che in tutti gli Stati operai era avvenuto un
cambiamento qualitativo per quanto riguardava il carattere degli stessi, poiché
erano passati da Stati operai degenerati (nel caso della ex Urss) o da Stati
operai burocratizzati (i restanti) a Stati capitalisti e, a partire da ciò, con
ritmi differenti, era iniziata la restaurazione del capitalismo.
In questo contesto, ancora in contrapposizione con quasi tutte le
organizzazioni e gli intellettuali di sinistra, segnalammo che la restaurazione
del capitalismo non era iniziata nell’Urss a partire dalla Perestroika di
Gorbachov, bensì in Cina, a partire dalle cosiddette “Quattro modernizzazioni”
votate dal Partito Comunista cinese nel 1978.
Anche contro l’idea molto diffusa che fossero state le masse, con
le loro mobilitazioni, ad aver posto fine agli Stati operai dell’Est europeo,
noi segnalammo che già prima delle grandi mobilitazioni questi avevano cambiato
il loro carattere, per cui le grandi mobilitazioni non si scontrarono con Stati
operai ma con Stati capitalisti, e che ciò che queste sconfissero furono i
regimi dittatoriali, di carattere borghese, guidati dai partiti comunisti.
In quegli anni c'erano molti (non tutti) che riconoscevano che il
capitalismo fosse stato restaurato nella ex Urss, ma praticamente nessun
settore della sinistra riconosceva che lo stesso fosse accaduto in Cina, in
Vietnam e a Cuba.Questa differenza di analisi esprimeva una profonda differenza
politica. Le correnti staliniste, o profondamente influenzate da queste (come
molte organizzazioni “trotskiste”), che affermavano che le mobilitazioni delle
masse avevano reso possibile la restaurazione del capitalismo, non sapevano
come spiegare la restaurazione in quei Paesi dove non erano esistite tali
mobilitazioni, com’era il caso del Vietnam o di Cuba, o dove queste
mobilitazioni erano state sconfitte, come era il caso della Cina.
Crediamo che la realtà stessa abbia confermato le nostre analisi,
al punto che oggi sono veramente in pochi a considerare che in Cina o in
Vietnam non sia stato restaurato il capitalismo, cosicché cresce il numero di
persone che si arrendono davanti all’evidenza e riconoscono che a Cuba sia
avvenuto lo stesso.
Mentre per quanto concerne la periodizzazione del processo
nell’Est europeo (prima cambiò il
carattere degli Stati e poi si ebbero
le grandi mobilitazioni contro i regimi) continua ad esserci, fino ad oggi, una
grande resistenza a riconoscere questo fatto, d’altra parte molto semplice da
comprovare. Basta studiare le date degli avvenimenti. La resistenza ad
accettare la realtà continua ad essere molto forte.
Però, come dicevo precedentemente, le nostre analisi e conclusioni
richiedono alcune precisazioni, e anche correzioni.
Il Verdetto ha il merito di segnalare che la restaurazione
del capitalismo non iniziò nella ex URSS e che un processo di questo tipo era
avvenuto, un decennio prima, in Cina. Tuttavia, il testo non prende in
considerazione che già negli anni ‘60, nella Yugoslavia di Tito, con la
politica dell’autogestione, furono fatti i primi passi per la restaurazione del
capitalismo. Se noi marxisti avessimo studiato questa realtà in profondità
difficilmente saremmo stati sorpresi, come fummo, dai processi in Cina e
nell’Est europeo, perché tutto indica che quanto accadde in Yugoslavia anticipò
ciò che più tardi doveva accadere, anche se in altre forme, nell'insieme degli
ex Stati operai.
Tuttavia, dal punto di vista dell'analisi, è necessario
evidenziare qualcosa che, seppur segnalato nel libro, non è sviluppato
chiaramente e, in più, a volte appaiono formulazioni contraddittorie. Mi
riferisco alla relazione tra il cambiamento nel carattere dello Stato (da
operaio a capitalista) e la restaurazione del capitalismo.
Nel libro si crea una certa confusione perché, in alcuni momenti,
si pone un segno di uguaglianza tra i due concetti.
Non è sufficientemente chiaro che la restaurazione del capitalismo
sorge come prodotto del cambiamento del carattere dello Stato quando la
borghesia, per mezzo dei suoi agenti, recupera il potere. E nemmeno è chiaro
che la presa del potere della borghesia avviene in un determinato momento (in
una data) ma, al contrario, la restaurazione del capitalismo è un processo che
si va a sviluppare nel corso del tempo.
Già Trotsky, negli anni ‘30 del Novecento, prevedendo la
restaurazione, metteva in allerta su questo tema. “Se una controrivoluzione
borghese avesse successo nell’Unione sovietica, per un lungo periodo di tempo
il nuovo governo tenderà a basarsi sull’economia nazionalizzata” (1). Questo è ciò che accadde in tutti gli ex Stati
operai, anche se non per “un lungo periodo di tempo”.
Questa precisazione è importante perché l’incomprensione riguardo
la relazione tra questi due concetti fece sì che molti pensassero (io tra
questi, fino al 1994) che continuavano ad esserci Stati operai perché la
restaurazione non era terminata o era “impantanata”, senza vedere che, a
partire dal cambiamento del carattere di classe dello Stato, la restaurazione
era inevitabile se una rivoluzione di carattere sociale non l’avesse impedita.
Infine, è necessario identificare un errore che esiste ne Il Verdetto, che pur essendo comune alla
quasi totalità delle organizzazioni che si rivendicano trotskiste, non per
questo cessa di essere tale.
I processi dell’Est, senza alcun dubbio provocarono una grande
confusione tra queste organizzazioni; il che portò a crisi, rotture e
disgregazioni. Questa realtà ci portò a dire qualcosa che, in quel momento,
sembrava ovvia a tutti noi: c'è “un approfondimento della crisi di direzione
rivoluzionaria…”. Queste sono le parole che compaiono nella prefazione alla
prima edizione de Il Verdetto, che
data 1995.
Questa idea è profondamente sbagliata. Trotsky, nel 1938,
considerando la debolezza della direzione rivoluzionaria in relazione alla
socialdemocrazia e allo stalinismo segnalò, con molta ragione: “La crisi
storica dell’umanità si riduce alla crisi di direzione rivoluzionaria” (2).
Questa crisi aveva due componenti. Da un lato, la debolezza
estrema della direzione rivoluzionaria e, dall’altro, il rafforzamento della
direzione controrivoluzionaria, giacché alla socialdemocrazia traditrice si era
sommato lo stalinismo.
Questa crisi di direzione rivoluzionaria si approfondì dopo la
morte di Trotsky. Da un lato, proprio per il suo assassinio, che rientra nel
genocidio di una generazione di rivoluzionari e, dall’altro, per il
rafforzamento dello stalinismo dopo la Seconda Guerra Mondiale, in funzione del
ruolo giocato dall’Urss (nonostante Stalin) nella sconfitta del fascismo. È
esattamente per questo che, nel dopoguerra, nel contesto di una grande ascesa
rivoluzionaria, si approfondì come non mai la crisi di direzione rivoluzionaria,
in quanto ci fu un rafforzamento qualitativo della direzione
controrivoluzionaria.
I grandi processi dell’Est, con la caduta dell’apparato stalinista
per l’azione rivoluzionaria delle masse, agirono in senso opposto a quanto
successo nel dopoguerra poiché, sebbene non ci fu una crescita importante della
già debole direzione rivoluzionaria, ci fu un indebolimento qualitativo della
poderosa direzione controrivoluzionaria, e questo liberò in larga misura il
cammino per provare a risolvere la principale contraddizione dell'umanità
segnalata da Trotsky.
La sfida programmatica
Le profonde trasformazioni avvenute negli ex Stati operai posero
due grandi sfide ai marxisti.
Da un lato c'era la necessità di comprendere quello che realmente
era accaduto (che è quello a cui mi riferivo precedentemente) e, dall’altro, la
necessità di trarre conclusioni in relazione alla prova alla quale fu
sottoposto il nostro programma.
Con la rottura della socialdemocrazia con il marxismo e la
degenerazione che rappresentò lo stalinismo, rimase nelle mani di Trotsky e dei
suoi compagni la responsabilità di dare un'interpretazione di ciò che avveniva
nella ex Urss e delle sue conseguenze a livello internazionale, così come dei
compiti che derivavano da questa comprensione per il proletariato. In questo
modo, negli anni ’30, in contrapposizione alla socialdemocrazia ed allo
stalinismo, si delineò il programma del trotskismo.
Quello che accadde negli ex Stati operai, particolarmente nella ex
Urss, mise alla prova questo programma
Dare una risposta a questa questione era la preoccupazione
centrale del libro che, appunto per questo, reca il nome Il Verdetto della Storia, poiché è di questo che si trattava: dare
un verdetto, a partire dagli avvenimenti, circa la validità e l’attualità, o
meno, del programma trotskista che, proprio come segnalò in tante occasioni
Nahuel Moreno, era, ed è - aggiungo io -, l’unica corrente marxista
dell’attualità.
La prova dei fatti
La Rivoluzione d’Ottobre rese possibile che la borghesia fosse espropriata,
che l’economia di mercato fosse rimpiazzata da un'economia centralmente
pianificata e che il commercio estero fosse monopolizzato dal nuovo Stato
operaio. Questo rese possibile uno sviluppo spettacolare dell'economia e della
cultura dell'ex Urss, e cosa che portò Stalin, già agli inizi degli anni ’30,
ad affermare che l’Urss fosse già uno Stato socialista, che marciava in
direzione del comunismo.
Trotsky, nel suo libro La
Rivoluzione Tradita, e in altre opere, sviluppò approfonditamente questo
tema, segnalando che l’Urss non era ancora uno Stato socialista (era in
transizione verso di esso) ma che i risultati ottenuti in meno di due decenni
mostravano “il diritto alla vittoria del socialismo”, poiché mai nella storia
dell'umanità un Paese arretrato aveva raggiunto tale sviluppo in così poco
tempo.
Ciononostante, mentre rimarcava questo, diceva che se la
burocrazia stalinista avesse continuato a dirigere lo Stato, in programma ci
sarebbe stato non il cammino verso il socialismo e il comunismo, bensì il
ritorno al capitalismo: “Il pronostico politico ha una natura alternativa: o la
burocrazia, convertendosi sempre di più nell’organo della borghesia mondiale
nello Stato operaio, distrugge le nuove forme di proprietà e farà ritornare il
Paese al capitalismo, oppure la classe operaia rovescerà la burocrazia e
libererà il cammino verso il socialismo” (3).
Trotsky faceva questa affermazione perché dietro la politica dello
stalinismo esisteva una teoria/programma. Era una teoria utile a giustificare
gli interessi di una casta parassitaria sorta all'interno dello Stato operaio.
Era la famosa teoria, inventata da Stalin contro tutta la tradizione marxista,
del “socialismo in un solo Paese”, che aveva un contenuto: l’abbandono del
trionfo della rivoluzione mondiale per sostenere, a partire da uno Stato
isolato, la “coesistenza pacifica con l’imperialismo”.
Gli accordi con Hitler prima, con gli americani e gli inglesi poi,
così come l’assassinio per ordine di Stalin di centinaia di migliaia di operai
e contadini, e tra loro quelli che avevano diretto la Rivoluzione d’Ottobre nel
1917, servirono per sostenere questa politica e, sei decenni dopo la sua
formulazione, il mondo poteva contemplare i suoi risultati: nel Paese
“socialista” di Stalin, che marciava in “direzione del comunismo”, il
capitalismo era stato restaurato; e la restaurazione non avvenne per mezzo di
un'invasione militare dell’imperialismo bensì, proprio come aveva anticipato
Trotsky, a partire dalla burocrazia al governo.
La realtà confermò il bivio prospettato da Trotsky, ma il
programma trotskista non si limitò a presentare pronostici alternativi, bensì
apportò una strategia per il trionfo dell'alternativa progressiva. Questa
alternativa era la difesa di una rivoluzione dentro la rivoluzione. Una rivoluzione
politica che doveva preservare le conquiste dell’Ottobre che ancora si
mantenevano (principalmente le imprese statalizzate, il monopolio del commercio
estero e l’economia centralmente pianificata) ma doveva espellere la burocrazia
dal potere affinché fosse la classe operaia con i suoi organismi, i soviet e il
partito rivoluzionario a porsi alla testa dello Stato.
Per avere sostenuto la necessità di sconfiggere la burocrazia,
Trotsky fu accusato di essere un controrivoluzionario dagli stalinisti, mentre
molti dei suoi seguaci si allontanarono da lui pensando che capitolava allo
stalinismo nel difendere, di fronte all’imperialismo, lo Stato operaio, seppur
degenerato.
Il verdetto della storia è stato demolitore. La classe operaia,
nonostante i suoi intenti (sollevamento rivoluzionario in Germania dell’Est,
Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia), non riuscì a schiacciare la burocrazia e
così, proprio come aveva detto Trotsky, la burocrazia, convertita nell'“organo
della borghesia mondiale nello Stato operaio, distrusse le nuove forme di
proprietà e fece ritornare il Paese al capitalismo”.
La restaurazione del capitalismo significò un regresso brutale
negli ex Stati operai, che già sono o stanno per divenire delle semicolonie
delle potenze imperialiste; e anche questo conferma la correttezza del
programma trotskista, l'aver difeso, nonostante la loro direzione, questi Stati
contro l’imperialismo, in quanto ciò significava difendere le conquiste della
Rivoluzione d’Ottobre.
La burocrazia riuscì a sconfiggere la rivoluzione politica e, per
questo, gli Stati operai furono distrutti; ciò dimostrò che solo i trotskisti
avevano un programma per evitare la restaurazione del capitalismo e riprendere
il cammino in direzione del socialismo.
Un chiarimento necessario
Nel nostro libro definiamo come “stalinista” non solo il governo
guidato da Stalin bensì tutti i governi che lo succedettero e, con la stessa
definizione, raggruppiamo correnti differenti tra loro. Questo tipo di
definizione sicuramente sorprenderà il lettore russo, perché non è così che in
Russia si è identificato ciò che venne dopo
della morte di Stalin.
Questa ampia utilizzazione della categoria di “stalinismo”
richiede, da parte nostra, una spiegazione.
Il cosiddetto periodo di “destalinizzazione” iniziato a partire
dal XX Congresso del Pcus, nel quale Nikita Krushev presentò il suo famoso
rapporto segreto in cui denunciava i crimini di Stalin, non significò una
rottura con l’essenza dello stalinismo: la coesistenza pacifica con
l’imperialismo, l'abbandono della rivoluzione mondiale, la negazione della
democrazia operaia, la politica internazionale di collaborazione di classe
mediante i fronti popolari e, a partire da tutto questo, i sistematici
tradimenti di tutte le rivoluzioni che minacciavano i suoi interessi e i suoi
accordi con la borghesia e l’imperialismo.
Per questo noi chiamiamo “stalinisti” i governi che succedettero a
Stalin, nonostante le loro denunce contro di lui. Perché queste denunce non
erano l'espressione di una lotta contro la burocrazia, bensì di una lotta
interburocratica per la successione di Stalin, in momenti nei quali il
malcontento delle masse cresceva in vari Paesi, compresa nell’URSS stessa.
Allo stesso modo, definiamo staliniste le differenti correnti che,
identificandosi o meno con Stalin, difendevano e difendono, nell’essenza, il
suo stesso programma. Concretamente mi riferisco al titoismo, al maoismo e al
castrismo.
In occidente si parla di differenti correnti del marxismo. Ci
sembra più corretto parlare di differenti correnti dello stalinismo. Non è per
caso che tutte queste correnti, con importanti differenze tra loro, adottarono
la medesima politica per affrontare le crisi nei propri Stati. Non fu la
politica dei bolscevichi di cercare nella rivoluzione mondiale l'aiuto necessario.
Fu quella di restaurare il capitalismo.
Infine, per chiudere questa presentazione, non posso fare a meno
di ripetere una cosa presente nell'introduzione alla prima edizione de Il Verdetto: “Lo Stalinismo e i suoi
successori, con i loro regimi di terrore, posero una barriera tra i marxisti
rivoluzionari del mondo capitalista e l’Est europeo. I rivoluzionari dell’Est
hanno iniziato ad abbattere queste barriere però, questo “felice incontro” non
è facile. È che in tutti questi anni di dispersione si sono costruiti
differenti linguaggi politici, differenze aggravate dalle barriere idiomatiche
che non sono poche né secondarie. A questo bisogna aggiungere che, per parte
nostra, come marxisti occidentali abbiamo mantenuto, in molti aspetti, una
visione – passi la ridondanza – “occidentale” sulle realtà che vivevano e
vivono questi Paesi. Quest’ultima cosa ci obbliga ancora di più ad essere
sommamente cauti e aperti nelle nostre elaborazioni, e a chiedere scuse
anticipate a questi compagni per gli errori che sicuramente commetteremo”.
Note
1) Lev Trotsky, “Né uno stato operaio né uno stato borghese?", 25 novembre 1937.
2) Lev Trotsky, “Il Programma di Transizione per la rivoluzione socialista”.