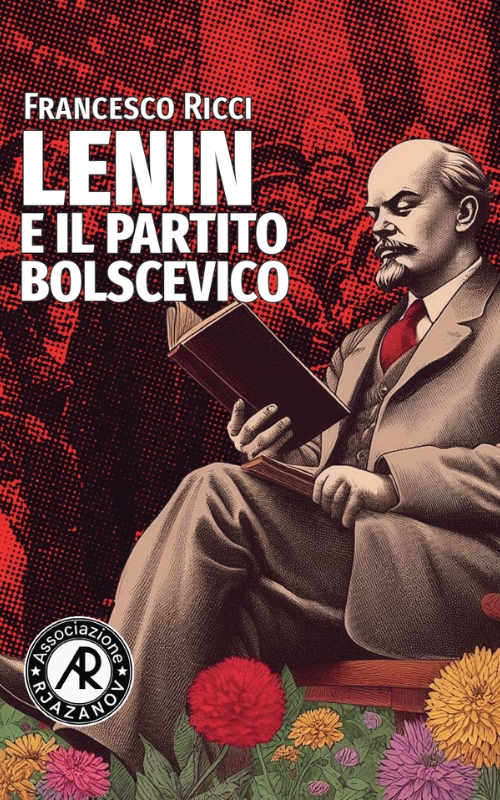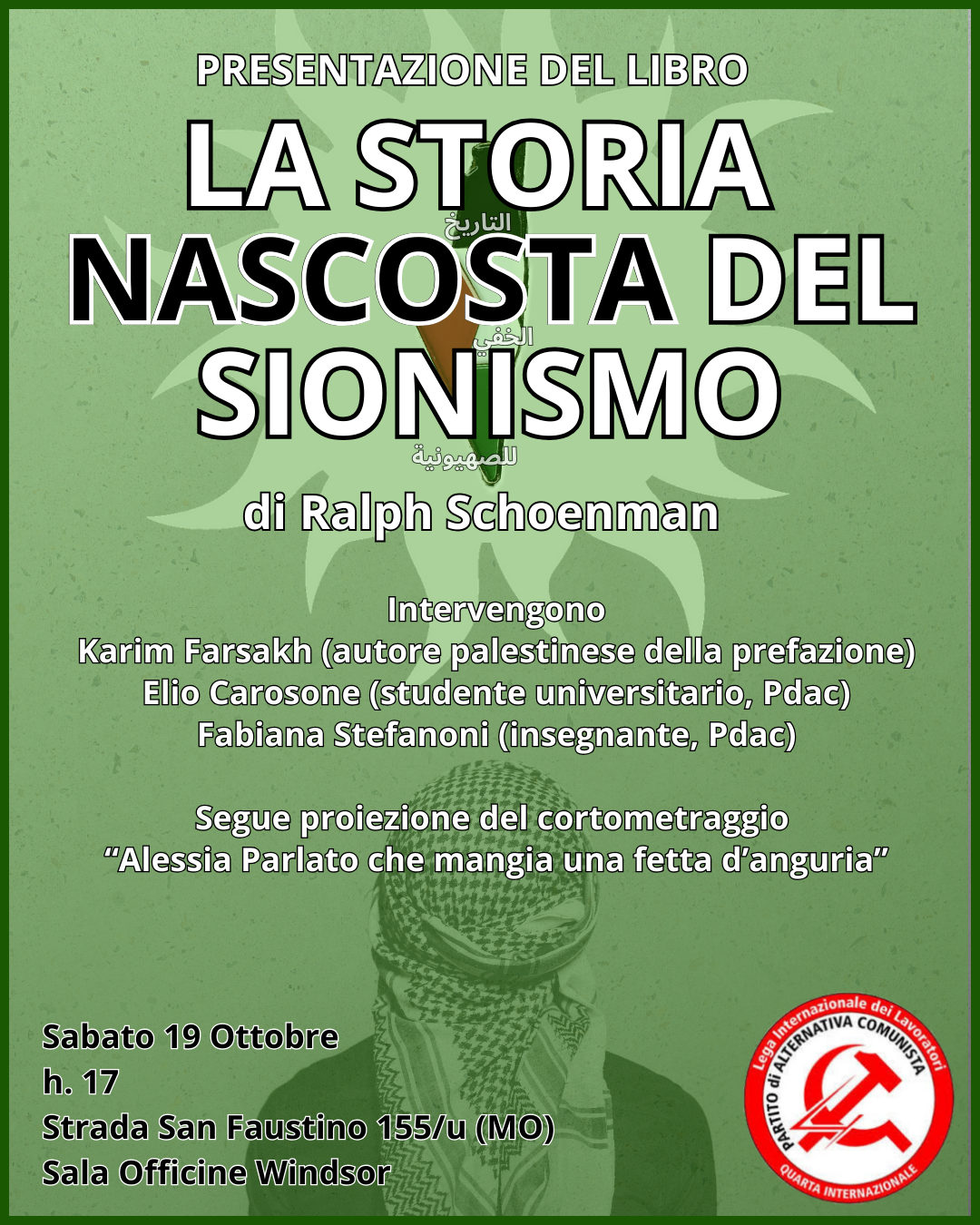L’ipocrisia dei «carbon credits» mentre la crisi climatica peggiora
di Roberto Tiberio

La questione climatica, ovverosia le analisi e i dibattiti sulle cause e le conseguenze del cambiamento climatico nonché sulle soluzioni per contrastarlo, non è un tema recente. La seconda rivoluzione industriale del XIX secolo ha innescato il processo di surriscaldamento del pianeta e da almeno cinquant’anni la comunità scientifica sta analizzando le conseguenze delle attività antropiche sul clima, prime fra tutte l’utilizzo dei combustibili fossili, il disboscamento incontrollato e lo sfruttamento delle risorse primarie.
Un sistema marcio
Negli ultimi decenni è cresciuta la consapevolezza che il problema dell’inquinamento impatterà sulla vita nel pianeta in un modo talmente decisivo da risultare irrisolvibile nel giro di poco tempo: da questa consapevolezza nascono e si sviluppano movimenti di masse popolari, soprattutto di giovani, che chiedono a gran voce soluzioni per invertire un processo che ad oggi pare irreversibile.
Le risposte concrete però latitano, perché partono da una premessa che va contro la soluzione. Se è vero, infatti, che l’attività umana nel suo complesso provoca inevitabilmente delle scorie, è altrettanto palese che il sistema capitalista che ci opprime, che ha come unico scopo il profitto (di pochi), è per sua stessa «natura» incompatibile con una gestione sostenibile delle risorse ambientali, anzi è causa della loro distruzione. Inoltre, come vedremo in seguito, le scorie che esso produce diventano merce da vendere e comprare nei mercati finanziari come qualsiasi altro prodotto.
Nel 1992 a Rio De Janeiro si è stipulato un trattato prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite, chiamato Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ha dato poi il via ai famosi incontri annuali (Cop) nei quali vengono firmati accordi, protocolli e stabiliti gli obiettivi futuri.
In origine tali accordi erano in sostanza non vincolanti per i Paesi aderenti; in seguito, con la ratifica di protocolli successivi (Kyoto 1997, Parigi 2015 ecc.), si fissavano tetti di emissioni da non superare. Tutto bello, sembra. Non proprio.
Se l’obiettivo principale infatti è quello di mantenere l’incremento della temperatura del pianeta sotto i 2 gradi, le azioni intraprese sono del tutto insufficienti.
I rapporti dell'Ipcc (Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici) e del Pnuma (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) hanno indicato la necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica ad un tasso del 7,6% all'anno fino al 2030, se si vuole mantenere l'obiettivo di rimanere al di sotto di un incremento di 1,5°C. Nella Cop27 è stato riconosciuto che è necessaria una riduzione del 43% delle emissioni di Co2 al 2030 rispetto al 2019, ma allo stato attuale, con gli impegni presi il taglio delle emissioni sarebbe solo dello 0,3% nel 2030 rispetto al 2019, un dato assolutamente sconcertante che mette in chiara luce tutti i limiti delle decisioni prese finora.
A tal riguardo, è fondamentale analizzare la strategia che soprattutto le multinazionali adottano per rientrare nei parametri di emissioni di gas inquinanti, che all’atto pratico altro non è che puro e semplice greenwashing.
I crediti «lava coscienza»
Il protocollo di Kyoto e il trattato di Parigi del 2015 hanno istituito i cosiddetti «carbon credits», cioè un mercato delle emissioni di carbonio che permette alle aziende che producono emissioni nocive - e non possono o meglio non vogliono ridurle - di comprare crediti di Co2 su mercati autorizzati.
Il sistema funziona, a grandi linee, nel modo seguente: un’azienda che, nel suo ciclo produttivo, genera inquinamento pari a 100, può acquistare crediti che compensano tale inquinamento per un valore di 50. Ne consegue che detta azienda può continuare a inquinare come ha sempre fatto e nel contempo dichiarare di avere dimezzato le emissioni, senza preoccuparsi ad esempio di passare a fonti di energia rinnovabili. E può etichettare i propri prodotti come «carbon neutral» rendendoli più appetibili sul mercato.
Le aziende possono acquistare crediti da altre aziende o, come succede nella maggior parte dei casi, da enti che certificano progetti atti in teoria a salvaguardare il clima: ogni credito è progettato per tenere conto di una tonnellata di carbonio rimossa dall’atmosfera o di una tonnellata in meno emessa. Tra i progetti più popolari dai quali si generano crediti ci sono quelli di salvaguardia delle foreste pluviali: impedendo che gli alberi vengono tagliati si garantirebbe un maggior assorbimento di anidride carbonica. Sarebbe già qualcosa, se non fosse che Bolsonaro e le multinazionali occidentali hanno devastato l’Amazzonia e le popolazioni indigene, in barba a ogni protocollo sul clima…
L’inquinamento è un affare
A gettare un’ombra profonda sul fallace sistema dei crediti carbonio è stata un’inchiesta del Guardian insieme a Die Zeit e SourceMaterial, dalla quale emerge che la stragrande maggioranza dei progetti volti alla conservazione delle foreste - quelli che producono crediti acquistati dalle aziende come compensazione alle emissioni di anidride carbonica - sono in realtà privi di efficacia e del tutto sovrastimati.
I crediti sono emessi da enti che valutano e certificano i progetti di sostenibilità ambientale, registrati in un archivio dal quale attingono le aziende compratrici. Il più grande di questi enti è Verra, oggetto dell’inchiesta. Tra i maggiori clienti di Verra troviamo multinazionali come Apple, EasyJet, Netflix, Barilla, Volkswagen, Air France e Shell, aziende che basano sulla compensazione delle emissioni la loro presunta strategia di riduzione delle emissioni.Verra calcola le riduzioni di emissione di carbonio da diversi tipi di attività secondo un proprio standard (Vcs) e immette crediti nel mercato, applicando una tassa per ogni credito emesso. Ha emesso l’85% dei crediti presenti sul mercato e, per fare ciò, il modo più semplice è quello di essere poco rigorosi nei parametri di valutazione, con tutte le conseguenze del caso. L’inchiesta, dopo un’analisi di una parte consistente dei progetti valutati da Verra, conclude che il 94% (!) di questi genera crediti fittizi che non producono reali benefici al clima. Un dato sconcertante.
Tesla vende auto? No, vende crediti
Nel settore dell’automotive succede lo stesso. Il mercato capitalista e la finanza aggirano legalmente il problema dell’inquinamento o, quantomeno, lo rimandano, permettendo alle aziende più inquinanti di comprare crediti verdi da altre aziende piuttosto che adeguare le loro infrastrutture o produrre veicoli meno inquinanti.
Il caso più emblematico è quello di Tesla, che, producendo solo auto elettriche, ha un surplus enorme di tali crediti (concessi dai governi) che vende ad altri costruttori con profitti enormi. Nel 2020 ha incassato 1,58 miliardi di dollari di soli crediti, molto più dei ricavi dalle auto.
Il gruppo Fca ora Stellantis ha potuto stipulare nel 2019 un accordo triennale con Tesla per il pagamento di 1,8 miliardi di dollari di crediti. Viene da chiedersi perché, posto l’obiettivo di combattere l’inquinamento del pianeta, debba essere permesso ad un’azienda considerata pulita (e Tesla non lo è, come non lo sono tutte le multinazionali che mirano al profitto) di vendere un fantomatico surplus di virtù invece di costringere gli altri ad adeguarsi.
La risposta è che in questo sistema socio-economico non è possibile. «Il ciclo di produzione del capitale è guidato dalla necessità dei profitti, del consumo più rapido e sempre maggiore di risorse naturali. Ciò porta all'attuale catastrofe climatica e alla depredazione della natura, poiché l'appropriazione continua delle risorse semplicemente non è compatibile con il tempo necessario per la ricomposizione dei cicli naturali» (citazione tratta da un articolo di Jeferson Choma del Pstu brasiliano).
Non possono essere i mercati e la corsa al profitto a combattere l’inquinamento: solo una società socialista nel rispetto dei cicli naturali e dell’uomo sarà in grado di restituirci un pianeta vivibile per tutti.