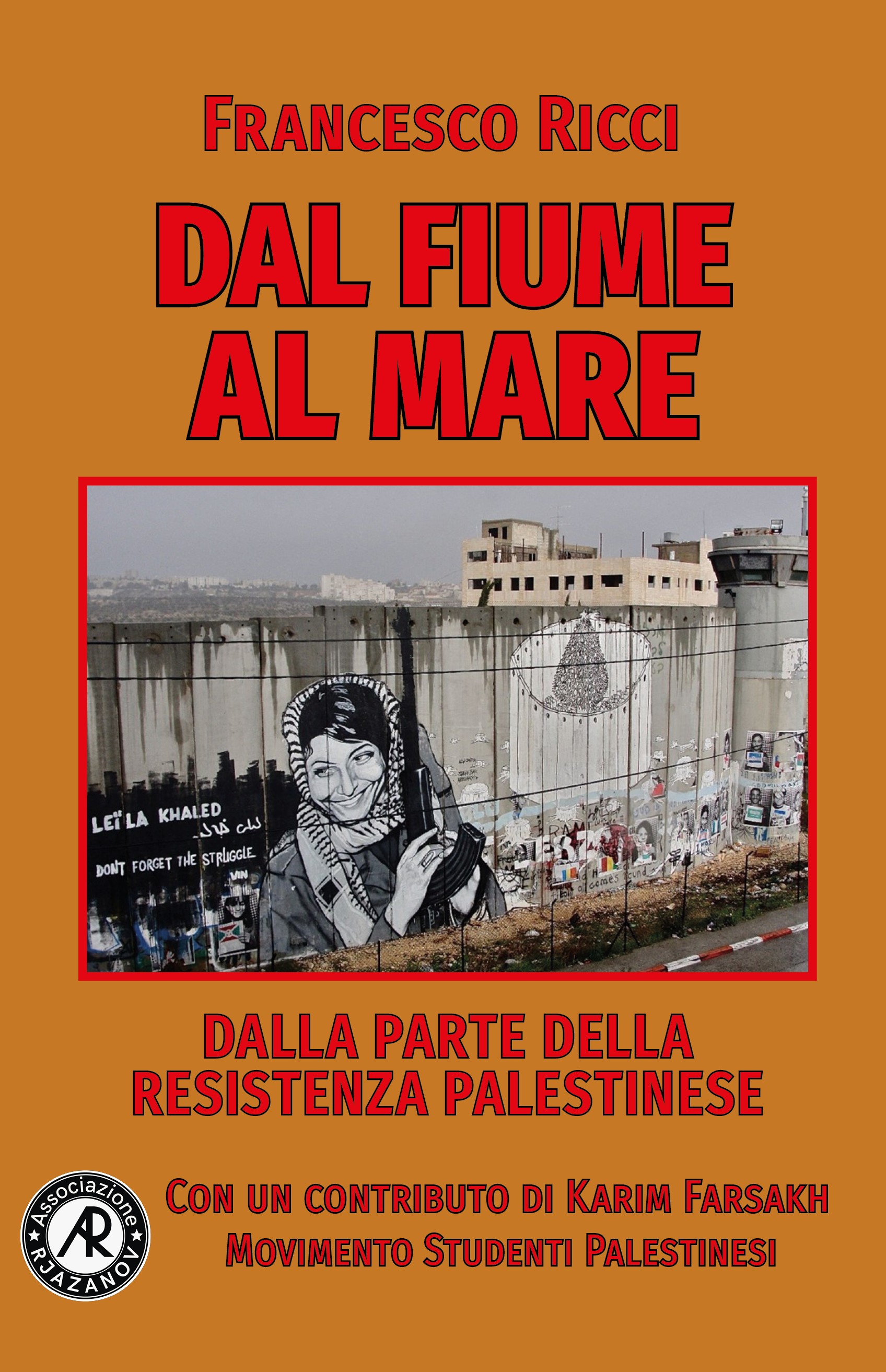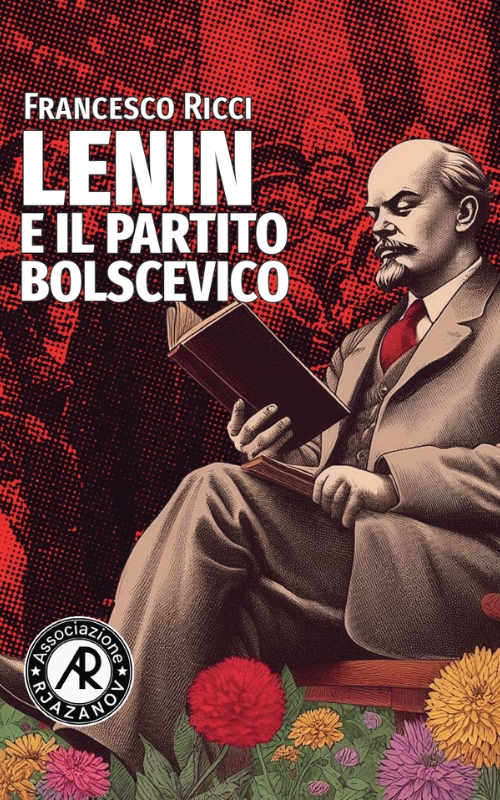70 anni di complicita’ dell’Onu
nell’apartheid in Palestina
di Soraya Misleh
Più
di seimila rifugiati politici, 5 milioni di rifugiati nelle campagne nel mondo
arabo, migliaia nella diaspora o sottomessi con occupazioni e razzismo in modo
disumano. Questa la situazione dei palestinesi, dopo 70 anni dalla
raccomandazione fatta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con al capo
il brasiliano Osvaldo Aranha, con un territorio diviso tra stato ebreo e arabo,
senza considerare l’opinione del popolo.
In
quel fatidico 29 Novembre del 1947, l’organismo internazionale allora appena
creato – originato dalla Lega delle Nazioni nella seconda guerra mondiale – ha
dato il via a una delle maggiori ingiustizie dell’era contemporanea: la pulizia
etnica in Palestina, che è sfociata nella creazione dello stato di Israele il
15 Maggio del 1948 (la Nakba – catastrofe per gli arabi), consolidando il
progetto sionista di una costituzione di uno stato omogeneo a maggioranza
giudaica. Dopo 12 giorni dalla raccomandazione dell’ONU, che proponeva di
concedere il 50% della Palestina a un movimento coloniale, iniziarono i
massacri e le espulsioni nelle città palestinesi. In pochi mesi, due terzi
della popolazione si ritrovò a essere rifugiata, 800.000 abitanti nativi, con
la distruzione di 500 villaggi, come viene descritto da diversi storici. Da
allora, la società palestinese rimane frammentata: le famiglie, divise e
disperse per il mondo, alle quali viene impedito di ritrovarsi nella propria
terra, la Palestina occupata.
Inoltre,
nonostante varie ondate di immigrazione di ebrei, provenienti soprattutto
dall’Europa dell’est e dall’Europa centrale, introdotte dal movimento sionista
alla fine del secolo XIX, nel 1947 gli ebrei non costituivano che il 30% del
totale della popolazione; la maggioranza erano musulmani, con alcune comunità
cristiane o laiche.
Gli
ebrei palestinesi hanno sempre rappresentato una minoranza. Israele, con la sua
politica di colonizzazione, ha trasformato definitivamente quella terra in un
luogo in cui non c’erano più distinzioni di credo o etnia. Al suo posto, ha
stabilito un regime di apartheid istituzionalizzato che dura tutt’ora.
Con
la benedizione delle grandi potenze e lo sforzo decisivo dei diplomatici di
paesi come il Brasile, nel quale all’epoca si intravedeva la possibilità di
avvicinarsi al nuovo imperialismo - gli Stati Uniti – lo stato che oggi si
autoproclama ebreo, fu creato nel 78% della Palestina storica. Inoltre,
violando la già ingiusta Risoluzione 181 dell’ONU (relativa alla divisione), questi
non hanno fatto nulla, a parte portare innumerevoli osservatori sul posto.
L’eccezione
fu l’emissario Conte Folke Bernadotte, che propose la revisione della divisione
del Paese in due parti e il ritorno incondizionato dei rifugiati palestinesi.
Arrivato in Palestina il 20 maggio del 1948, è stato assassinato dai sionisti
nel settembre dello stesso anno, come scrisse lo storico israeliano Ilan Pappé,
ne “La pulizia etnica della Palestina”, quando ha ripetuto la raccomandazione
nel rapporto finale che ha presentato all’Onu.
L’organizzazione
non solo “ha rimandato” e relegato il documento nei suoi archivi, come è
successo negli Stati Uniti e nell’Unione Sovietica con Stalin (i primi a
riconoscere Israele) e come altri paesi, tra cui il Brasile in prima fila.
Con
questa “politica” e al servizio dell’imperialismo, l’ONU non ha tentennato nel
riconoscere Israele come Stato membro meno di un anno dopo il nakba (l’11
Maggio del 1949) e, a fronte di uno scenario allarmante di migliaia di
rifugiati. Nello stesso anno ha creato la UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite
per l’assistenza di questa popolazione, che è stata costretta a insediarsi in
tende minuscole, in condizioni precarie, nelle campagne del mondo arabo. Invece
di preoccuparsi di presentare una soluzione per il problema al quale ha
contribuito decisivamente, l’ONU è passato – tramite la sua agenzia – a
contabilizzare e registrare questi palestinesi, che hanno dovuto sopportare di
fare lunghe file per ritirare i loro cappotti e un’insufficiente percentuale di
“aiuto umanitario”. Come racconta mio padre, Abder Raouf, nel Al Nakba, uno
studio sulla catastrofe palestinese (Editrice Sundermann), che si ritrovò
rifugiato nella città di Qaqun nel 1948 a 13 anni, questo aiuto consisteva nel
concedere un dollaro al mese per ogni palestinese. “Al mese distribuivano 1 kg
di fagioli, 1 kg di farina, un pezzetto di sapone, 200 grammi di olio di soia.
Ogni famiglia, come noi per esempio, aveva 5 figli, più mia madre e mio padre;
quindi, arrivavamo là, facevamo la fila per ricevere quel minimo di sostegno
per far passare la fame”, scrive. L’11 dicembre del ’48 le Nazioni Unite
emettono la Risoluzione 194, che viene rivendicata come un importante documento
di riconoscimento del diritto legittimo e inalienabile di ritorno di tutti
quelli che sono stati espulsi dalle loro terre e di compensazione per le loro
perdite. Di fatto, relegata ai suoi archivi, senza alcuna applicazione pratica.
Nel
1967, Israele ha occupato militarmente, durante la cosiddetta Guerra dei 6
giorni, il 22% restante della Palestina, ossia la Cisgiordania, Gaza e
Gerusalemme Orientale. Questa è l’unica parte del territorio che l’Onu
considera territorio occupato abusivamente. Nella proposta dei due Stati,
questa sarebbe la parte destinata ai palestinesi. Una legittimazione
inaccettabile dalla teoria della pulizia etnica inaugurata con i suoi auspici e
la sua complicità 20 anni prima.
Da
allora, sono centinaia le risoluzioni delle Nazioni Unite per la condanna a
Israele per la violazione dei diritti umani e la colonizzazione illegale delle
terre ma, vale la pena ripeterlo, niente è mai stato applicato effettivamente.
Oslo, una “seconda nakba”
L’
“alternativa” degli Stati consigliata dall’Onu e fortemente raccomandata da
tutto il mondo come “appoggio ai palestinesi” è stata poi accettata formalmente
dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) nel 1988. Creata
il 28 Maggio del 1964 sotto la guida di Yasser Arafat, questa ha messo da parte
la sua rivendicazione storica, basata sulla sua Carta dei Principi, di
formazione di uno Stato unico palestinese, laico, libero e democratico,
antirazzista e quindi, la fine del progetto sionista.
Il
punto di rottura c’è stato alla fine della prima Intifada palestinese (rivolta
popolare), iniziata nel 1987, quando sono stati firmati nel settembre del 1993
gli accordi di Oslo tra la OLP e Israele, con l’intermediazione degli Stati
Uniti.
Con
questa opportunità, Oslo è riuscita nel suo intento mascherato a contenere la
resistenza sotto la falsa apparenza della pace e della convivenza, firmando il
riconoscimento reciproco tra la OLP e Israele e creando la Autorità Nazionale
Palestinese (ANP), i cui accordi si basavano su quella proposta dei due stati.
L’idea
diffusa al mondo era che il controllo del 22% del territorio palestinese
occupato nel 1967 passasse gradualmente ai palestinesi. Inizialmente, la
Cisgiordania sarebbe rimasta divisa in area A (amministrata dalla ANP – 18% del
territorio), Area B (mista, tra Israele e ANP, 22% del territorio), e area C (sotto
controllo militare esclusivo dei sionisti, 60%).
Un
anno dopo, a completare il quadro, sono stati firmati i Protocolli di Parigi,
che hanno sigillato la conseguente cooperazione di sicurezza della ANP con
Israele; in altre parole, l’Autorità Palestinese è poi passata al controllo
dell’occupazione, reprimendo la resistenza dei palestinesi. La questione
economica è la chiave di questo processo: qualsiasi fondo, importazione o
esportazione da parte della ANP, da allora è soggetta alla supervisione israeliana,
che ha assicurato il controllo sulla circolazione via terra, via mare e sulle
frontiere. Come frutto di questo processo, è sorta una nuova borghesia nella
Palestina occupata, legata al progetto sionista, come spiega Adam Hanieh,
esperto di economia politica. In questo
clima di pacificazione, con una dipendenza totale dalla ANP, il risultato non
poteva essere differente: normalizzazione delle relazioni da parte della nuova
classe capitalista palestinese, per mezzo dell’apartheid e dell’occupazione.
Anche
quando, a partire da allora, alcuni palestinesi hanno appoggiato questa
proposta – non per portarla a termine ma perché non c’era nessun’altra uscita –
altri, non per caso, si riferiscono a questo episodio come una “seconda Nakba”
e una resa da parte della OLP. L’intellettuale palestinese Edward Said ha
definito subito l’accordo, chiamandolo “Trattato di Versailles della causa
palestinese”. Non poteva usare similitudine migliore.
Con
la ANP come garante dell’occupazione, come segnala la giornalista Naomi Klein
nel suo libro “La dottrina della rottura – l’ascesa del capitalismo del
disastro”, Israele ha visto facilitare l’ampliamento del suo progetto: tra il
1993 e il 2000, il numero di coloni israeliani si è duplicato. Oggi sono
600.000 in Cisgiordania.
Come
dimostra l’autrice, Oslo è stato il punto di inflessione nella politica che è
sempre stata alla base della pulizia etnica dei palestinesi. Dal 1948 fino ad
allora, c’era una certa indipendenza economica, la quale è stata interrotta.
“Tutti i giorni, quasi 150.000 palestinesi lasciavano le loro case di Gaza e
della Cisgiordania per pulire le strade e costruire le autostrade in Israele,
allo stesso tempo gli agricoltori e i commercianti riempivano i camion con
prodotti da vendere in Israele e in altre parti del territorio, descrive Klein
nel suo libro. Dopo gli accordi del 1993, lo stato ebraico si è chiuso a questa
manodopera che sfidava il progetto sionista dell’esclusione di quella
popolazione. Contemporaneamente, Israele pian piano si presentava, con le
parole della giornalista, “come una specie di shopping center di tecnologia di
sicurezza nazionale”. Nel suo libro, l’autore afferma che a fine 2006, anno
dell’invasione israeliana nel Libano, l’economia dello stato sionista, basata
fortemente sull’esposizione militare, si è espansa vertiginosamente (8%), e
allo stesso tempo si è accentuata la disuguaglianza all’interno della stessa
società israeliana, e il tasso di povertà nei territori palestinesi occupati
nel 1967 hanno raggiunto indici allarmanti (70%).
“Campi di pace”
La
soluzione dei due stati è sostenuta anche dalla cosiddetta “sinistra” sionista,
che si presenta al mondo come “il campo della pace”. In altre parti del mondo,
questo significherebbe almeno una preoccupazione accentuata dalla componente
sociale ed economicamente sfavorevole di una certa società. Il campo della pace
di Israele si è concentrato esclusivamente in manovre diplomatiche dalla guerra
del 1973, un gioco che non è molto considerato per molti, dice Ilan Pappé,
nella sua “Storia della Palestina Moderna”.
Nella
rassegna sulla rivista “Falsi profeti della pace”, di Tikwa Honig-Parnass, il
“Ijan” (Rete internazionale di Ebrei Antisionisti”) dimostra che, storicamente,
la “sinistra” sionista era decisamente allineata al progetto di colonizzazione
della Palestina come lo era la destra. “Come dimostra questo libro, da prima
della fondazione dello stato di Israele, la sinistra sionista parlava troppe
volte la lingua dell’universalismo, mentre aiutava a creare e mantenere sistemi
giuridici, governi e l’apparato militare, che hanno permesso la colonizzazione
delle terre palestinesi”. La radice di questa sinistra è nel cosiddetto
“sionismo laburista”, costituito all’inizio della colonizzazione, dalla fine
del XIX secolo e inizi del XX. I suoi membri rivendicavano l’aspirazione di
principi socialisti e coltivavano, come informa il testo del Ijan,
deliberatamente questa falsa idea.
I
diari dei laburisti dell’epoca dimostrano la loro intenzione non dichiarata,
quella di assicurare il “trasferimento” degli abitanti nativi (arabi non ebrei
soprattutto), come già anticipato, dalle loro terre e l’immigrazione di ebrei
venuti in Europa per colonizzare la Palestina: un eufemismo per indicare la
pulizia etnica. “In uno dei suoi momenti più sinceri, David Ben-Gurion,
principale dirigente di questo gruppo e capo del movimento laburista sionista
(che sarebbe diventato primo ministro di Israele nel 1948), ha confessato nel
1922 che “l’unica grande preoccupazione che domina il nostro pensiero e
attività è la conquista della terra, attraverso l’immigrazione di massa (alià).
Tutto il resto è solo fraseologia”. L’articolo cita ancora un’altra
osservazione di Honig-Parnass: “Nel 20° congresso Sionista del 1937, Ben-Gurion
difendeva la pulizia etnica della Palestina (…) per aprire il cammino per la
creazione dello stato Ebreo”.
Indipendentemente
dall’autoproclamarsi di “sinistra”, “centro” o “destra, il sionismo aveva come
obiettivo la conquista della terra e del lavoro, ciò che dovrebbe essere
esclusiva degli ebrei. Per questo motivo, la centrale sindacale israeliana
Histradrut – ancora esistente e fondamento dello stato coloniale, proprietaria
di società che sfruttano i palestinesi – ha avuto un ruolo centrale e il suo
rafforzamento è stato difeso dai sionisti di “sinistra”. In altre parole, la
differenza tra i laburisti e i revisionisti come Netanyahu è che questi ultimi
erano – e sono sempre – più sinceri.
L’idea
di uno Stato palestinese minimo per interrompere la resistenza è figlia anche
del padre del sionismo revisionista, Zeev Jabotinsky. Questi ha pubblicato nel
1923 un articolo intitolato “The Iron Wall” (La muraglia di ferro), nel quale
dissacra possibili differenze con gli obiettivi della “sinistra” e della
“destra” sionista, denunciando la retorica dei primi. Nonostante il disprezzo
dichiarato nei confronti dei palestinesi, dice chiaramente: come già successo
con tutti i colonizzati, gli arabi sono un popolo vivo e, mantenendo un minimo
di speranza di liberarsi dalla colonizzazione delle loro terre, lottano per
questo. Questi propone di avvicinare i palestinesi alla muraglia di ferro della
forza militare giudaicaper fare in modo
che, tra i “Moderati”, non ci possa essere nessuno che cerchi un’alternativa
per non accettare le briciole proposte dai colonizzatori. Qualsiasi somiglianza
tra Oslo e la ANP non sono semplici coincidenze. L’unico partito che oggi si
autoproclama sionista di sinistra è il Meretz, creato negli anni del 1990. Come
segnala Ilan Pappe ne la “Storia moderna della Palestina”, il nuovo gruppo di
“colombe pragmatiche” è sorto dalla fusione del “Movimento di diritti civili”
di Shulamit Aloni, un partito liberale dalla linea dura chiamato Shinui
(“Cambiamento”), e il partito socialista “Mapam”. L’autore aggiunge:
“pragmatismo in questo caso significa una venerazione tipicamente israeliana di
sicurezza e discussione, non un giudizio di valore sulla pace come concetto
preferito, né simpatia per questo problema dall’altra parte del conflitto, né
riconoscimento del suo ruolo nella creazione del problema”.
La
“sinistra” sionista continua con la sua trappola, il suo “canto della sirena”.
Innalzandosi a favore della pace, cerca di spegnere o giustificare la Nakba.
Razionalizza l’affermazione della natura democratica di uno stato ebreo e
difende la logica di “divisi ma uguali”, ovvero, le stesse briciole ai
palestinesi, promulgate dall’Onu, per buona parte dei suoi Stati membri (136 di
193) e anche dalla sinistra mondiale.
L’idea
degli Stati come unica via d’uscita, già ingiusta perché non contemplava la
totalità del popolo palestinese, inclusa la maggioranza che si trova fuori
dalle sue terre, e i 1,5 milioni che vivono nei territori dal 1948 (oggi
Israele) e sono sottomessi alle leggi razziali – si scoprì essere inattuabile
di fronte all’avanzamento della colonizzazione e dell’apartheid israeliano
soprattutto dopo Oslo.
Gli
1,8 milioni di palestinesi di Gaza vivono in un assedio disumano da quasi 10
anni e una crisi umanitaria aggravata poi dai successivi bombardamenti
israeliani e i massacri. La Cisgiordania e la Gerusalemme Orientale si trovano
a essere totalmente segregate e il risultato è un territorio frammentato, senza
legami tra una città e l’altra. Strade esclusive collegano gli insediamenti che
sono sorti nei territori occupati militarmente nel 1967. Oggi, pensare a questa proposta suonerebbe
come legittimare il regime istituzionalizzato dell’apartheid, con uno Stato
diviso in specie di “bantustani” (1), senza alcuna autonomia, in meno del 20%
del territorio storico della Palestina. Questa “soluzione” è sepolta, come
riconoscono gli esperti sul tema come Ilan Pappé, ed è necessario smascherarne
il suo significato.
La soluzione giusta
In
occasione di ogni 29 Novembre, quando si festeggia il giorno internazionale
della Solidarietà con il Popolo Palestinese, istituito dall’Onu nel 1977 per
ricordare la data in cui è stata legittimata la colonizzazione criminale che ha
seguito, è necessario rafforzare in tutto il mondo campagne centrali come
quella del BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni) su Israele e andare
più in là: alzare la bandiera dell’unica possibilità di giustizia, ossia uno
Stato Palestinese unico, laico, democratico, non razzista, con diritti uguali
per tutti e sancire così la fine del progetto sionista.
Per
rafforzare questa bandiera, si rende necessario creare con urgenza
un’alternativa ai vecchi dirigenti. Un’alternativa che contribuisca
all’organizzazione e unificazione dei lavoratori palestinesi e ai movimenti di
avanguardia della gioventù, a partire da una direzione rivoluzionaria
conseguente. Il cammino per una Palestina libera che, a differenza di quanto si
vuole dimostrare al mondo, non passa per le istituzioni tradizionali come
l’Onu, ma attraverso trasformazioni profonde in tutto il mondo arabo e la
caduta dei suoi regimi dittatoriali alleati all’imperialismo. Questa via è
possibile e ancora praticabile.
Note
(1) Territorio riservato ai neri sudafricani in funzione della sua appartenenza linguistica ed etnica: occupano circa il13% del territorio sudafricano; il Sudafrica ha creato questo tipo di confini per rafforzare la sua politica dell’Apartheid.
*Traduzione a cura della redazione web